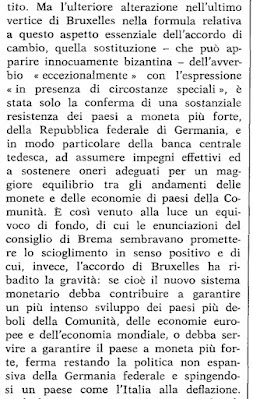(…mi dimenticherò perché ho scritto questo post, ma una di voi non lo dimenticherà. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod…)
Goofynomics
L’economia esiste perché esiste lo scambio, ogni scambio presuppone l’esistenza di due parti, con interessi contrapposti: l’acquirente vuole spendere di meno, il venditore vuole guadagnare di più. Molte analisi dimenticano questo dato essenziale. Per contribuire a una lettura più equilibrata della realtà abbiamo aperto questo blog, ispirato al noto pensiero di Pippo: “è strano come una discesa vista dal basso somigli a una salita”. Una verità semplice, ma dalle applicazioni non banali...
giovedì 3 aprile 2025
mercoledì 2 aprile 2025
Autonomia, federalismo e sovranità popolare
(...di seguito il testo della mozione Molinari-Bagnai, poi qualche breve considerazione...)
Premesso che
grazie alla guida del Segretario Matteo Salvini e al lavoro del Ministro Roberto Calderoli, dopo 23 anni dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione e dopo 7 anni dai referendum indetti dalle Regioni Lombardia e Veneto, il Parlamento ha approvato la legge sull’autonomia differenziata, battaglia storica della Lega.
La Lega ha sempre denunciato apertamente fin dalle sue origini, ma ancora di più sotto la guida di Matteo Salvini, i malfunzionamenti della costruzione UE, che dall’ambizione di essere una organizzazione sovrastatale finalizzata alla pace e prosperità, si è trasformata nei fatti in strumento di cristallizzazione dei rapporti di forza e prevaricazione di alcune economie su altre, ma soprattutto in esecutrice di politiche finalizzate a far prevalere interessi economici di poche élite a danno dei Popoli europei, privati dalle attuali regole dei trattati di un vero potere di controllo e decisione su scelte che impattano pesantemente sulla loro vita quotidiana.
Considerato che
il percorso dell’autonomia differenziata, come ampiamente prevedibile, sta incontrando la resistenza delle burocrazie statali ministeriali e ha subito anche un ridimensionamento con la pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare per quanto riguarda la non esclusività delle competenze legislative devolvibili alle regioni e il sistema di finanziamento mediante compartecipazione al gettito statale per le regioni;
l’Unione Europea invece di avviare una seria riflessione sui suoi malfunzionamenti, sembra intenzionata con la Commissione von der Leyen ad allargare ulteriormente le competenze in campi come quello della difesa, abbandonandosi a una deriva bellicista che scaricando i costi del riarmo sui bilanci nazionali bloccherebbe la spesa sociale del nostro Paese, inibisce il contrasto alla deindustrializzazione, che è invece stata accelerata dall’adesione acritica all’agenda ecologista, ma soprattutto non pare intenzionata ad affrontare in modo strutturale il tema delle diseguaglianze sociali, conseguenza necessaria di quelle politiche di repressione salariale reciproca fra Stati membri di cui Mario Draghi ha citato l’impatto nefasto sul nostro stato sociale, attribuendole all’adozione di politiche fiscali procicliche determinata dalle regole fiscali dell’eurozona. A fronte di questo la Commissione von der Leyen mantiene un atteggiamento ambiguo, che da una parte sembra voler proseguire sulla linea del rigorismo finanziario, ma dall’altra consente a Paesi come la Germania e la Francia di violare patentemente le regole, ampliando le asimmetrie che minano la stabilità del progetto europeo.
Preso atto che
si rende necessario proseguire sul percorso tracciato dell’autonomia, dell’attuazione del federalismo fiscale, ma al contempo porsi nuovi obiettivi e strategie per avvicinare sempre di più i livelli decisionali ai territori, nel rispetto di identità, ambizioni e vocazione di ogni singola area del Paese, contrastando l’evidente deriva centralista di Bruxelles, che sta progressivamente ampliando lo spazio di intervento pubblico sotto il diretto controllo della Commissione, a detrimento dei margini di autonomia lasciati alle istanze nazionali e territoriali.
Il fallimento della globalizzazione e delle istituzioni che la governano, evidenziato nell’Unione Europea dalla grave sofferenza sociale, congiunta a un’esplosione del debito pubblico, causate dall’intervento della cosiddetta “troika” (espressione usata per definire il concerto istituzionale fra Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea), suggeriscono l’opportunità di una gestione bilaterale e su base funzionale dei rapporti internazionali, che veda nell’atlantismo un riferimento imprescindibile e scongiuri lo sterile antagonismo con gli storici alleati statunitensi che permea la retorica europeista.
Negli ultimi 20 anni la forbice fra la ricchezza dell’1% della popolazione più ricca e il 90% della popolazione più povera nel nostro Paese si è allargata più che mai: l’1% più ricco è passato dal detenere il 17% al 21% del totale della ricchezza, mentre il 90% più povero è passato dal 55% al 44%. Il reddito di diplomati e laureati oggi è inferiore a quello di fine anni ‘80, così come quello degli operai. La forbice fra il reddito del 10% dei lavoratori più ricchi e il lavoratore mediano è cresciuta in media di quasi 10 punti percentuali. Dal 2013 al 2023 più di 300 mila cittadini italiani con un titolo universitario hanno lasciato il Paese per trasferirsi all’estero, i giovani emigrati sono stati 377 mila.
Considerato altresì che
La prospettiva di Stati Uniti d’Europa è superata nei fatti dal crescente ricorso all’approccio intergovernativo. Questo non è un male, considerando che nel lessico europeo si intende per “federalismo” un maggiore accentramento delle risorse e della loro gestione, tramite un bilancio unico europeo finanziato da debito comune europeo, cioè un centralismo in contrasto con la storica battaglia della Lega per l’autonomia.
Peraltro, la tensione centralista dei movimenti europeisti sarà sempre frustrata dal rifiuto francese di una politica di difesa comune, dal rifiuto tedesco di strumenti di debito comune, dall’assenza di una costituzione che offra tutte le tutele democratiche, a partire da una efficace rappresentanza dei territori. Di conseguenza, sta emergendo nel dibattito l’opportunità di adottare un percorso alternativo di integrazione europea, basato sul modello della “coalizione dei volenterosi“, cioè su un insieme di trattati intergovernativi a geografia variabile, distinti su base funzionale, che consentano agli Stati membri di unirsi, al limite coinvolgendo anche Stati non membri, su temi specifici sui quali la cooperazione offra un mutuo vantaggio. Questa idea ha una lunga tradizione (il processo di integrazione europea nasce da accordi su materie prime ed energia come la CECA e l’Euratom) ed è tutt’ora attuale (si pensi agli accordi stretti dalla Germania con la Russia, Paese non membro, in ambito energetico, o agli accordi in corso col Regno Unito sul tema della difesa comune europea). Un simile modello si tradurrebbe nella sostituzione della costosa burocrazia di Bruxelles, resa ipertrofica dal suo desiderio di imitare un ipotetico Stato nazionale, con agenzie più snelle e più focalizzate sui singoli aspetti funzionali da gestire con trattati specifici. Si supererebbe così l’approccio totalizzante basato sull’integrale accettazione dell’“acquis communautaire” da parte di ogni potenziale Stato membro, approccio alla base dell’asfissiante iper-regolamentazione europea.
Il Congresso della Lega Salvini Premier impegna il Segretario e il Movimento
- A promuovere, nelle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale, forme sempre più strette di collaborazione e allineamento normativo per aree macroregionali, in modo da poter dare risposte migliori e più organiche alle esigenze dei territori su temi come ad esempio il TPL, l’ambiente, la sanità, la ricerca o le politiche industriali, valutando anche percorsi istituzionali per la creazione di macroregioni.
- A porsi come priorità dell’azione politica nel Governo la piena attuazione dell’autonomia differenziata e del federalismo fiscale. Inoltre, ottenuta l’autonomia, a portare avanti una riforma costituzionale che trasformi l’Italia in uno Stato Federale, prevedendo per le Regioni una maggiore devoluzione di competenze legislative e autonomia fiscale, e superando il bicameralismo paritario, che risulta già ampiamente superato dalla prassi legislativa vigente, attribuendo alla Camera competenza esclusiva sulle questioni di interesse nazionale, mentre un Senato delle regioni dovrebbe occuparsi delle materie concorrenti fra Stato e Regioni ed avere voce sulle riforme costituzionali e sui trattati internazionali.
- Ad opporsi a qualunque nuovo allargamento delle attuali competenze dell’UE, avendo avuto svariate prove che l’attuale struttura non garantisce la democraticità delle decisioni, e a proporre un modello di governance basato su una pluralità di nuovi trattati concepiti su base funzionale e a geografia variabile, cui aderiscano inizialmente i principali paesi per PIL e Popolazione. Questa nuova architettura di Trattati dovrebbe porsi il fine di costruire democraticamente un mercato comune in cui il potere d’acquisto interno, la lotta alle diseguaglianze partendo da una tassazione unica nell’area euro per le multinazionali, la difesa della produzione interna e gli investimenti in istruzione e politiche sociali siano la priorità, mettendo da parte il liberismo economico e il rigorismo di bilancio a favore del benessere dei cittadini europei.
- Inoltre, al fine di evitare che gli squilibri causati dalla moneta unica compromettano l’armonico sviluppo degli Stati membri, a favorire la revisione delle attuali regole di bilancio per consentire ai bilanci nazionali di svolgere una funzione di riequilibrio degli sbilanci interni all’Unione, misurando la capacità fiscale degli Stati non sull’entità del loro debito pubblico, ma su quella del loro surplus estero, e prevedendo penalizzazioni per gli Stati che non promuovono gli investimenti pubblici allo scopo di mantenere una posizione di surplus strutturale, sulla base delle regole già previste dalla procedura sugli squilibri macroeconomici (MIP).
Riccardo Molinari
Alberto Bagnai
Alcune brevi considerazioni, partendo da quello che qui sappiamo e ci unisce, ma soprattutto dal contesto complessivo in cui ci troviamo, quello della deglobalizzazione. Il fallimento delle istituzioni multilaterali, che hanno lasciato macerie un po' ovunque in giro per il mondo, anche qui da noi, come la tardiva resipiscenza di Draghi certifica, mette un partito come la Lega di fronte a un interessante trade-off. Il passaggio a un modello bilaterale o comunque intergovernativo, anziché sovranazionale o federale, di gestione delle relazioni internazionali (relazioni che esistono da quando esiste la storia e che mai sono state gestite come pretendiamo di gestirle qui, peraltro), richiede un Governo nazionale forte e autorevole, uno Stato centrale incisivo e rappresentativo, che sia un interlocutore rispettato sui vari tavoli intergovernativi o bilaterali, lasciando dietro di sé l'illusione che ha caratterizzato la gestione PD del Paese, quella che le istituzioni europee fossero concepite nel nostro interesse, e quindi che bastasse affidarsi ad esse, accompagnarle, per trarre dalla propria subalternità la garanzia di avere un posto a tavola nei consessi internazionali:
(Luigi si sbagliava, il tweet è ancora qui).
Questo può sembrare in contrasto con la storica battaglia leghista per l'autonomia, una battaglia che nel tempo ha avuto sporadicamente episodi o toni anche acuti, potenzialmente eversivi, ma che, va sempre ricordato, è iscritta saldamente nei principi fondamentali della Carta costituzionale:
Come conciliare l'esigenza di uno Stato nazionale forte e autorevole verso l'esterno, con il rispetto delle autonomie? La mozione segue due percorsi: considerare l'alternativa, e prendere sul serio l'autonomia.Partirei dal primo, che a noi è più familiare. L'alternativa a una emancipazione dello Stato nazionale qui da noi è la prospettiva "federalista" europea, che, vorrei ricordarlo, di "federalista" come comunemente si intende nel dibattito nazionale non ha nulla, perché il sogno dei federalisti europei è l'accentramento del maggior numero di funzioni in un governone sovranazionalone, dotato di bilancione comune e di debitone comune europeo. L'incubo di un pensiero genuinamente autonomista e federalista: un accentramento livellatore della diversità e della ricchezza dei singoli territori! L'inesorabile svolgersi dei fatti ha fatto giustizia anche di un'altra illusione: quella che fosse desiderabile l'integrazione di alcune Regioni, le più progredite del Paese, con la cosiddetta "locomotiva" tedesca, in spregio al fatto che quella "locomotiva", come notava Napolitano nel 1978, come i dati ci indicano, in realtà era un vagone che cresceva sistematicamente e intenzionalmente sotto la media europea, e alla ragionevole presunzione che lo scorpione tedesco avrebbe inevitabilmente punto la rana europea al primo torrente in crisi che si fossero trovati ad attraversare. Qui noi lo abbiamo fatto sempre notare, anche quando eravamo di sinistra: Milano ladrona, Berlino non perdona! Lo abbiamo poi ribadito anche da poco, esaminando i dati a livello di dettaglio regionale:
Non solo l'integrazione monetaria non ha significativamente accelerato quella commerciale, reale, limitandosi a squilibrare nel senso del deficit le relazioni fra le regioni produttive e la potenza manifatturiera tedesca:
ma oggi si pone addirittura il tema strategico di un decoupling da quella che alcuni continuano a chiamare locomotiva (la Germania(, ma che è a tutti gli effetti la zavorra del sistema economico europeo, data la sua connaturata riluttanza a spingere sull'acceleratore della domanda interna (che la porta ad andare a fondo quando distrugge o si preclude mercati di sbocco), cioè un tema di diversificazione (da parte di chi ancora non l'abbia fatto) del "rischio Germania"!
Quello che sfugge a chi nel partito è sospettoso rispetto alle prospettive di recupero della sovranità popolare è che l'alternativa difficilmente può essere quella di una mitologica "Europa delle regioni" o degli improbabili "Stati Uniti d'Europa", e in particolare che questi ultimi, quand'anche fossero possibili (ma non lo sono, per vari motivi di cui alcuni vantano un antichissimo lignaggio), condurrebbero all'esatto contrario di quello che riteniamo sia giusto.
Si pone quindi fortemente il tema di una riorganizzazione delle relazioni in ambito europeo, volta da un lato a formalizzare e disciplinare quella dimensione intergovernativa che regola de facto le relazioni fra Paesi, e dall'altro a armonizzare sulla base di principi economici sensati le politiche macroeconomiche degli Stati nazionali. Insomma: un po' come qui da noi, anche in Europa si pone un problema di allineamento della costituzione formale a quella materiale, reso più complesso, naturalmente, dal fatto che una costituzione formale in Europa non c'è perché non può esserci (verum factum convertuntur).
Qui, però, abbiamo ben chiari quali potrebbero essere due modelli da seguire. Nelle relazioni fra Stati, ci ha sempre convinto l'approccio delle giurisdizioni funzionali sovrapposte, che qui descrivemmo tredici anni or sono (il testo originale è qui). Si tratterebbe di tornare alle origini, quando, come è ben noto, le buone relazioni fra i duellanti (Francia e Germania) vennero stabilite sulla base di accordi funzionali (sulle materie prime, sull'energia, poi sul commercio).
Nell'armonizzazione delle politiche macroeconomiche, dopo che perfino Giavazzi ha dovuto ammettere che il problema dell'Unione erano gli squilibri fra Paesi, gli squilibri di bilancia dei pagamenti:
è assolutamente ovvio che l'impianto delle regole di bilancio andrebbe completamente sovvertito secondo la nostra vecchia proposta di "external compact":
La proposta è articolata e va dettagliata: magari lo facciamo nei commenti, ma il senso complessivo è che converrebbe fare in tempi normali e in termini espansivi quello che oggi siamo costretti a fare in tempi di crisi e quindi necessariamente in termini espansivi, cioè assegnare lo strumento delle politiche di bilancio all'obiettivo dell'equilibrio degli scambi intra-zona. Bisognerebbe insomma che prima delle crisi chi ha una bilancia dei pagamenti in surplus investisse, invece di aspettare la crisi per chiedere a chi ha la bilancia del pagamenti in deficit di tagliare gli investimenti. In questo caso we have tools (cit.): i criteri da applicare già esistono, sono quelli della Macroeconomic Imbalances Procedure, e basterebbe prenderli sul serio, assistendoli con meccanismi di incentivo (preferibili alle sanzioni, che all'atto pratico non hanno avuto grande successo).
Poi c'è la parte "prendere sul serio l'autonomia", cioè di come assicurare che le aspirazioni dei territori siano rispettate, le loro potenzialità pienamente espresse, e la loro voce trovi spazio nelle sedi da cui può avere proiezione internazionale, che poi sono quelle del Governo centrale. La proposta qui è quella di riflettere su un ordinamento di tipo federale, analogo per certi versi a quello adottato da un altro Paese di recente unificazione (la Germania), con due revisioni istituzionali di rilievo, oltre a prevedere l'attribuzione al livello regionale di competenze più penetranti: il superamento del bicameralismo paritario e il ridisegno su base funzionale del ritaglio amministrativo, con l'idea, se non di creare macroregioni, che potrebbe essere un obiettivo, almeno di immaginare forme di collaborazione e allineamento amministrativo su scala macroregionale nelle materie che tipicamente incombono attualmente sulle Regioni (sanità, trasporti, ambiente, ecc.).
Su almeno una di queste cose, il superamento del bicameralismo paritario, credo sappiate come la penso. Quando si trattò di votare sulla Riforma Renzi-Boschi io fui fieramente avverso, non solo per ragioni politiche, ma anche perché i motivi addotti a supporto erano piuttosto fragili, e non avendo lavorato all'interno di una istituzione parlamentare non potevo individuare i punti di debolezza del modello paritario. La nostra proposta è diversa da quella di Renzi e Boschi, e parte da un lato dall'esigenza di avere una connessione fra Parlamento e territorio che non sia affidata alla buona volontà del singolo parlamentare ma abbia una dimensione istituzionale più rilevante e incisiva, e dall'altro dal riconoscimento che il modello paritario nel contesto di una legislazione essenzialmente di iniziativa governativa contribuisce a inibire più che rafforzare il controllo parlamentare. In un Paese più piccolo e meno sfaccettato del nostro forse riterrei preferibile il modello finlandese (Parlamento monocamerale con Commissioni "forti"), ma nel nostro una articolazione un po' più aderente alla lettera della Costituzione:
un Bundesrat, mi sembra molto difendibile. Sono allergico ai #facciamocome tanto quanto ai #fatepresto, ma sono anche abbastanza insofferente verso le cose che non funzionano, e non posso raccontarmi che le cose come sono adesso funzionino, perché non è vero (e il problema non è "la navetta", come si diceva all'epoca della Renzi-Boschi...).
Sul tema delle "macroregioni" ci sarebbe un discorso ampio da fare e non sono sicuro di essere preparatissimo per farlo. Certo è che, anche qui, pur non essendo un fanatico delle economie di scala, devo riconoscere che nella fornitura dei servizi affidati alle Regioni spesso dei problemi di scala si pongono, e sarebbe stupido disconoscerli. Del resto, non a caso una provincia limitrofa sta valutando, fra innumerevoli difficoltà, di ricongiungersi al mio amato feudo dell'Abruzzo Citra. Ci sarebbe poi da riflettere se l'organo su cui puntare per gestire il territorio sia la Regione o la Provincia, quale Regione, quale Provincia. Certo è che la riforma Delrio, chiesta da Draghi:
di macerie ne ha lasciate, e il problema di come ricostruire non possiamo non porcelo.
Bene, tanto vi dovevo. Mi sono iscritto a parlare per illustrare la mozione, non so se lo farò così, sicuramente mi aiuteranno i vostri commenti. Quando il blog iniziò, e quando (pochi mesi o anni dopo) elaborammo o esponemmo le varie proposte di cui vi ho parlato e che oggi sono in una mozione congressuale, mai avrei pensato di essere chiamato a intervenire a un congresso di partito, né che quella chiamata alle armi che da voi mi proveniva, quella richiesta pressante di tradurre in proposte politiche concrete le analisi di questo blog, avrebbe potuto avere una realizzazione così compiuta in termini simbolici e sostanziali.
Ogni tanto succede anche qualcosa che non mi aspetto, devo riconoscerlo, e devo anche esservi riconoscenti perché se è potuto succedere, questo, indubbiamente, è anche grazie a voi.
Dichiaro aperta la discussione generale.
martedì 1 aprile 2025
They have tools
Credo ricordiate tutti la frase minacciosa pronunciata dalla presidente della commissione:
"If things go in a difficult direction we have tools":
Suppongo che ricordiate anche la sorprendente esternazione dell'uterino Thierry Breton:
"On l'a fait en Roumanie...".
Do poi per scontato che tutti ricordiate questa esternazione:
la prima (è del 2013) e la migliore, perché è del Migliore: il pilota automatico che avrebbe proseguito sulla rotta di quelle stesse riforme di cui oggi il Migliore disconosce la paternità. Il pilota non era poi così automatico, in realtà: era lui che manovrava lo spread decidendo di smettere di acquistare i titoli dei governi "nemici", ma insomma, noi non serbiamo rancore, ci basta essercelo tolto di torno e averlo visto balbettare.
Qual è il punto?
Il punto è che da dodici anni Essi(TM) ci dicono di avere strumenti, e questi strumenti sono relativamente diversificati: un tempo le banche centrali (che ora non possono usare, perché un'aggressione via spread metterebbe in seria difficoltà la Francia, come si è visto al tempo di Madame uì ar not ir to cloz ze zpredz), oggi le alte (o basse) corti, domani (ma anche oggi), altre autorità, tutte caratterizzate però da una qualità peculiare: quella dell'indipendenza: l'indipendenza della Banca centrale, l'indipendenza della magistratura, le autorità amministrative indipendenti...
Si torna quindi a uno dei punti nodali del discorso che stiamo svolgendo qui, fin dall'inizio: indipendenti da chi? L'indipendenza è una relazione simmetrica: se A non dipende da B, si assume che B non dipenda da A. Ma se A non dipende da B, e B condiziona A, allora A è sottomesso a B, e se A è espressione democratica di un popolo, allora la democrazia ha un problema. E in effetti è così, come credo sia evidente. L'indipendenza di certe istituzioni (anche qualora si fondi, come quasi mai è il caso, sul dettato della Carta costituzionale) da ipotetico presidio di democrazia è diventata una reale minaccia per la democrazia, è diventato il fondamento del potere coercitivo di cui alcuni si avvalgono per sovvertire le decisioni dei più a beneficio degli interessi di pochi.
Il fatto che sia un problema di difficile soluzione non implica che non dobbiamo riconoscerlo come tale.
Tanto vi dovevo, e torno a lavorare.
domenica 30 marzo 2025
QED 107: il Giavazzo bifronte
Ho fatto male questa mattina a maramaldeggiare sulla sorprendente papera del Prof. Ing. Giavazzi. Ho fatto male perché, nell'accesso di ilarità causatomi dallo strafalcione del supercilioso oracolo, ho tralasciato di leggere il suo pezzo. C'è un motivo per cui il Prof. Ing. Giavazzi non mi invita particolarmente alla lettura: perché trovo decotte e tendenziose le sue analisi. Faccio a meno di andare dove so che mi si vuole portare, soprattutto se so che la direzione che mi si indica è quella sbagliata (e di questo vi darò qualche esempio). Leggere i pezzi del Prof. Ing. Giavazzi insomma non è molto più appagante che leggere l'ennesima COM europea, anzi, forse un filo meno. Però, purtroppo, in entrambi i casi questo sacrificio va fatto. Nel caso del Prof. Ing. Giavazzi, in particolare, sorbirsi le sue articolesse è utile per comprendere dove a Bruxelles vogliano andare a parare. E se avessi letto anche di corsa il resto del pezzo di oggi avrei trovato una parola che, come sapete, è un marker infallibile dell'ipocrisia mielosa e classista con cui chi ci ha avviato sulla strada del declino ha voluto esentarsi dalle proprie responsabilità: deprezzamento!
Ricordate?
Ne abbiamo parlato qui.
Ma procediamo con ordine e ripercorriamo rapidamente la storia delle piroette del Giavazzo bifronte. Sarà utile e istruttiva...
In principio era il debito pubblico!
La prima piroetta del Giavazzo bifronte, quella in cui il supercilioso oracolo sdoganò l'idea che il debito pubblico si poteva fare (ma solo se comune, e preferibilmente per armarsi) ha colpito molto l'immaginazione dei turisti del dibattito:
Molto meno la nostra, non solo perché il "momento Hamilton" (cioè la spinta a costruire, sull'onda emotiva di uno stato di eccezione, un debito comune) e il keynesismo bellico li stiamo vedendo arrivare da tempo, ma anche perché questa piroetta non era la prima, in effetti, ma la seconda!
Chiarisco.
Tutti ci ricordiamo i bei tempi in cui Giavazzi (che oggi lo nega) vedeva nel debito pubblico (che era più basso di quello attuale, ancorché fatto crescere dalle politiche attuate da Monti e sponsorizzate dalla Bocconi unanime), la causa di tutti i mali. Può essere utile ripercorrere qualche quotidiano dell'epoca. Pesco a caso dalla rassegna stampa questo articolo del febbraio 2014:
animato dai soliti toni parenetici, in cui il magico duo Alesina e Giavazzi, con una certa aristocratica condiscendenza, si attardava a ricordarci che:
Il primo problema del nostro Paese era insomma "erdebbitopubblico". E come ti sbagli!
Il protrettico duo ribadiva il concetto ad ogni piè sospinto! Così, a settembre:
nell'ansia di inculcare il timore per il debito, capitava loro (sbadati!) di regalarci una pericolosa ammissione:
ovvero che i tedeschi avevano violato le regole per finanziare a deficit la loro "riscossa". Certo, racconto lacunoso e disonesto il loro: intanto, i tedeschi non avevano chiesto alcun permesso, tant'è che la procedura di infrazione era partita:
(cosa che ovviamente non sarebbe successa se avessero negoziato una escape clause di qualche tipo, come Alesina e Giavazzi insinuavano) e la sua storia la trovate qui; ma soprattutto, Alesina e Giavazzi dimenticavano di dirvi quello che voi sapevate, cioè i motivi di questo sforamento: il finanziamento a deficit di una gigantesca svalutazione salariale (taglio del cuneo e spesa assistenziale per i nuovi poveri delle riforme Hartz). Noi ne avevamo parlato in dettaglio due anni prima del loro pezzo affrettato e menzognero.
Ovviamente, se il problema era "erdebbitopubblico", la soluzione non poteva essere la spesa pubblica: non solo la spesapubblicaimproduttiva cara a un altro grande economista, quello che non aveva avuto il Nobel ma l'Oscar, e non negli Stati Uniti ma al fonte battesimale! Secondo i nostri ineffabili mentori neanche gli investimenti andavano aumentati! Infatti a novembre, nell'ammonirci esortandoci a sottrarci alla tentazione irresistibile:
i nostri, categorici, affermavano che:
Eh, no! Non si poteva uscire dalla recessione con gli investimenti pubblici. Strano, perché i dati ci dicevano che in recessione ci eravamo entrati tagliandoli, come vi ho fatto vedere qui:
Ora, per completa onestà intellettuale (materia sconosciuta al magico duo, ma di cui qui abbiamo sufficiente abbondanza da poterla esportare anche senza svalutare troppo i nostri avversari, o almeno da non svalutarli più di quanto si svalutino da sé con le loro piroette): posso anche ammettere che gli investimenti pubblici siano soggetti ad una strana asimmetria per cui si fa prima a tagliarli che a espanderli, ma questa asimmetria andrebbe esplicitata! Invece nel resoconto del formidabile duo i dodici trimestri di recessione sembrano venuti fuori dal nulla, come la famigerata "grande moria delle vacche". Alesina e Giavazzi come Totò e Peppino, insomma, incapaci di individuare le cause della recessione, e per questo incapaci di proporre soluzioni con un minimo di tenuta logica.
Il massimo che proponevano, i due, era una applicazione del moltiplicatore di Haavelmo:
Un taglio di tasse con taglio di spesa (per non far esplodere il debito pubblico, ça va sans dire), quando al primo anno di economia si studia che una simile manovra è recessiva, e quindi fa esplodere il rapporto debito/Pil! Il tutto con gran rinforzo di argomenti grillini: le lobby (perché, la Bocconi che cos'è?), la corruzione (non esiste solo quella materiale, esiste anche quella intellettuale)...
Non voglio infierire ulteriormente sulla povertà deontologica e intellettuale di certi argomenti. Chi arriva qui da poco, come l'amico che si firma "il forestiero", potrebbe vedere in questo resoconto un esercizio del senno di poi. Mi fermo quindi, e passo a dimostrare che in realtà era il magico duo a essere perennemente in ritardo.
Contrordine compagni: il problema non è il debito pubblico!
Beh, questa la sapete. Un annetto dopo le stronzate banalità scritte qua sopra, il supercilioso censore della politica italiana dovette ammettere che:
Esattamente il punto da cui eravamo partiti noi a novembre 2011 ne I salvataggi che non ci salveranno, traendo però da questa analisi giusta e tempestiva la prescrizione giusta, cioè che i tagli alla spesa pubblica che Giavazzi ancora chiedeva nel 2014, essendo fatti per curare un sintomo (il debito pubblico) che non era la causa della malattia, avrebbero aggravato la malattia (e quindi il sintomo), come poi fu. Il fact checking su Monti vi dà evidenza plastica delle conseguenze di questo errore (oltre a ricordare tutte le fonti più o meno coeve che un po' in ritardo, ma molto più autorevolmente di me, affermavano prima del Giavazzo bifronte quella che era un'evidenza palmare: se a saltare per aria erano stati tanti Paesi a debito pubblico trascurabile, come si poteva affermare che il debito pubblico fosse la causa del problema?).
Va detto che né il Giavazzo bifronte né i suoi sodali, scrivendo sullo house organ del capitalismo renano (Voxeu), potevano dare il giusto risalto al perché si fossero creati quegli squilibri che poi avevano necessariamente condotto al sudden stop, all'arresto improvviso del rifinanziamento delle posizioni debitorie della periferia (Grecia, Spagna, Portogallo, ecc.) da parte del centro (Germania, Francia). Sull'aggressiva svalutazione dei salari tedeschi, di cui, come vi ho provato per tabulas, era consapevole, l'ineffabile, oracolare accademico sorvolava con eleganza.
Ma quello, e non il successivo, era un voltafaccia vero, autentico, profondo, una rivoluzione copernicana che all'epoca nessuno notò, tranne uno, l'uomo seduto sulla sponda del fiume:
Contrordine compagni: il debito pubblico fa bene!
Perché il secondo voltafaccia, quello da cui siamo partiti, quello con cui il Giavazzo bifronte, deposti i panni dell'ingegnere e indossati quelli dell'economista, si ricordava che in recessione si possono fare investimenti pubblici a debito, era assolutamente prevedibile, come pure era prevedibile che dopo aver demonizzato la spesa pubblica per decenni, una volta costretti dai fatti a ricorrere ad essa avrebbero dovuto giustificare questa necessità sulla base di uno stato d'eccezione, del più convincente degli stati di eccezione: la guerra. Un esito scontato, che avevamo anticipato diverse volte, ad esempio qui:
(scritto otto anni fa, ma direi che c'è tutto quello che stiamo vedendo accadere).
Questo (cioè il fatto che questo voltafaccia fosse banale e ampiamente anticipato) e la mancanza di tempo mi hanno impedito di esercitarmici a suo tempo, ma altri hanno fatto per me: Goofynomics è una bottega rinascimentale...
In principio la svalutazione era brutta e cattiva!
Dopo esserci fatti un'idea dell'uomo, della sua poliedricità, della sua political economy, veniamo quindi all'oggi, che però deve essere inquadrato alla luce di una premessa che risale a un passato ormai parecchio distante: quello in cui il Giavazzo bifronte sosteneva che sarebbe stato opportuno per l'Italia legare le proprie mani allo SME:
(il famoso SME credibile che sarebbe poi saltato come un tappo di prosecco tiepido, con grande scorno dei due Paperoga Frankel e Phillips). Qui avete altre versioni del lavoro, nel caso non vi riesca di scaricarlo da ScienceDirect, la versione pubblicata dall'NBER contiene anche una interessante discussione.
L'argomento dell'incomparabile, che va sempre in duo, come solitamente fanno altre entità che non nomino per rispetto, e che all'epoca, per l'occasione, si accompagnava a Pagano, era sostanzialmente che:il vantaggio di partecipare al Sistema Monetario Europeo (e quindi, a maggior ragione, all'euro) sarebbe stato quello di impedire riallineamenti nominali che compensassero i differenziali di inflazione. In questo modo i governi non si sarebbero abbandonati alla tentazione di inflazionare l'economia (sempre sacerdotale, il nostro supercilioso mentore - o mentitore?), perché se ogni aumento del differenziale di inflazione rispetto ai Paesi partner si fosse tradotto in un apprezzamento del cambio reale senza possibilità di compensazione la crescita sarebbe stata danneggiata, inducendo così i governi a scegliere spontaneamente un sentiero di crescita meno inflazionistico.
Sempre questo partito preso, sempre questo moralismo, sempre questo individualismo metodologico che ignora la complessità del reale, sempre questo ciarpame...
Vabbè, mi rendo conto che a quasi quarant'anni di distanza questo pezzo di modernariato scientifico può risultare sostanzialmente incomprensibile. Andrebbe contestualizzato (come tutte le produzioni intellettuali scarse, dal Manifesto di Ventotene in giù: i classici di contestualizzazioni non ne hanno gran bisogno...), con riferimento al dibattito sulla superiorità delle regole rispetto alle politiche discrezionali e sugli altri grandi temi che appassionavano all'epoca la scienza economica "normale" nel senso di Kuhn. Ma il main takeaway, incontestabile, è che all'epoca il nostro ieratico, supercilioso commentatore, che temprando lo scettro ai regnatori la spesa ne sfronda, era radicalmente contrario alla possibilità per un Paese come l'Italia di manovrare il cambio nominale, e anzi sosteneva che un cambio "credibile" (e quindi stabile) avrebbe portato benefici in termini di minore inflazione (e quindi a tendere di maggiore competitività, cioè di minore apprezzamento del tasso di cambio reale).
Che quelle che lui vedeva come svalutazioni della lira fossero in realtà rivalutazioni del marco non gli passava nemmeno per l'anticamera del cervello, perché tutto intento ad agghindare con festoni di integrali puramente esornativi le sue articolesse tecnico-ingegneristiche:
figurati se l'oracolo di viao magari si ponesse una cazzo di domanda, una sola, sul perché la Germania, la potenza industriale, la locomotiva, ecc., strutturalmente crescesse meno dell'Italia:
tranne nei periodi in cui riusciva o a far rivalutare noi (nello SME credibile, dopo il 1988) o a svalutare lei (con la svalutazione salariale del 2003), o a imporci politiche recessive (con l'austerità dal 2011).
Avranno mica avuto ragione i comunisti come Napolitano quando (13 dicembre 1978) dicevano che:
la compressione della crescita da parte della Germania federale faceva parte di una deliberata politica di aggressione volta a spingere alla deflazione un paese come l'Italia?
Eh, i comunisti... averne, averne, io ve lo dico sempre!
Nei 14 anni precedenti l'articolessa del duo Giavazzi-Pagano la Germania era cresciuta al 2% e l'Italia al 3%. Sarà mica che i tedeschi comprimevano la loro crescita per mantenere un posizione di surplus nei riguardi del resto del mondo (via compressione delle importazioni)? Un dubbio, una ipotesi, un passaggio, qualcosa, lo vogliamo fare? Erano ipotesi agli atti parlamentari! Erano entrate nel dibattito pubblico! Che quella tedesca fosse una politica aggressiva di deflazione competitiva lo si vedeva bene anche allora, lo vedeva perfino Napolitano, persona garbata e intelligente, ma non economista.
Non ho sufficientemente approfondito l'opus magnum di cotanto economista, ma dubito che di questa roba si troverebbe traccia: il suo astio verso il Paese che gli ha dato i natali gli precludeva, gli preclude, e gli precluderà, la possibilità di qualsiasi analisi che non sia pregiudizialmente ostile verso l'Italia e gli italiani.
Contrordine compagni: la svalutazione va bene, ma solo se la chiamiamo deprezzamento e se siamo in surplus!
La cosa turpe, abietta, vile dell'odierna esternazione del sommo e supercilioso ierofante può ora essere messa in evidenza, e non è certo la ridicola papera in cui è inciampato (ben gli sta, ma può capitare a tutti). No: è il fatto che dopo aver detto, come da sempre diciamo io e Claudio, che mettere dazi da parte dell'UE non avrebbe senso:
il supercilioso apostolo della religione misterica bocconiana ci dice lellero lellero che:
la chiave della soluzione sta nel deprezzamento dell'euro!
Affermazione sorprendente e sciocca.
Sciocca, perché, come vi ho mostrato, è proprio il deprezzamento dell'euro, che essendosi manifestato in presenza di una fortissima eccedenza delle partite correnti non può che essere qualificato che come svalutazione competitiva, ad aver causato la risposta ampiamente annunciata degli Stati Uniti. Dire che bisogna reagire ai dazi proseguendo con la pratica scorretta che li ha motivati è come dire che se andassimo a trattare negli Usa insieme ai tedeschi saremmo accolti meglio! Significa aver perso il lume della ragione, significa non avere una lettura un minimo equilibrata della realtà in cui ci dobbiamo muovere. Tralasciamo la scorrettezza di intestarsi, come al solito, idee espresse in precedenza da altri: l'uomo è così, lo avevamo capito nel 2015.
Sorprendente, perché non si capisce come mai i deprezzamenti che negli anni '80, che erano chiaramente rivalutazioni del marco conseguenti alla politica tedesca di compressione della domanda interna, dovessero essere demonizzati dall'ineffabile, supercilioso bramino come svalutazioni competitive, mentre oggi una manovra al ribasso della valuta di una zona che esprime 500 miliardi di dollari di surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti viene pudicamente invocata come benefico deprezzamento, essendo, lei sì, una svalutazione competitiva!
Insomma: l'articolessa di oggi è il QED del post di venerdì, quello in cui notavo come fosse strano che chi trovava turpe che si deprezzasse il cambio di un Paese in deficit trova virtuoso che si deprezzi il cambio di un'area in surplus! Questa è economia di base, non è sufficientemente controintuitiva, non è sufficientemente matematizzabile, e quindi i veri economisti la snobbano, e gli ingegneri non la capiscono. Si deprezza la valuta di un Paese in deficit, perché si rivaluta quella del Paese in surplus (essendo richiesta per comprarne i beni). Neanche la legge della domanda e dell'offerta sanno questi pomposi, superciliosi, presuntuosi tromboni!
Ma loro scrivono sul Corsera. E noi scriviamo, fieramente e ostinatamente, qui, aspettando l'inevitabile.
Perché che quella che Giavazzi oggi chiede a beneficio dell'industria tedesca sia una svalutazione competitiva i lettori del Corriere non possono saperlo.
Ma i governanti degli altri Paesi sì, soprattutto di quelli più grossi di noi e della Germania!
Si rafforza quindi la principale conclusione politica: dissociarsi rapidamente e recisamente dai responsabili degli squilibri macroeconomici globali, andare a trattare bilateralmente con gli Stati Uniti, e soprattutto: non leggere il Corsera!
Tanto vi dovevo sulla terza piroetta del derviscio rotante dell'economia comme il faut.
Gli insulti metteteli voi, ma non nei commenti, per cortesia.
Buonanotte!
(...ah, naturalmente la chiave della soluzione sta nel componimento degli squilibri interni all'Eurozona, e questo, volendo escludere l'opzione per il momento improponibile di una uscita dall'euro, si può realizzare solo come dicevamo noi nel 2014 e come sicuramente dirà lui nel 2026: gli auguro di arrivarci non fosse che per leggerlo! Ma ve ne parlerò commentando la mozione congressuale che ho contribuito a scrivere con Riccardo Molinari...)
La svalutazione penalizza l’export
(…è in qualche modo un QED di questo post…)
La lunga sequenza di piroette (la colpa è del debito pubblico, no di quello privato; bisogna fare austerità, no bisogna fare debito…) deve aver fatto girare la testa all’ingegner Giavazzi, che oggi, su un quotidiano che noi associamo spontaneamente al concetto di lieve imprecisione, ci regala una perla da mettere al verbale di questo blog, perché occorre che una volta di più si attesti la qualità (infima) dei personaggi che, dettando la linea dei quotidiani cosiddetti autorevoli, hanno distrutto la credibilità della professione accademica e, dato non banale, delle associazioni di categoria.
Non c’è male, eh? Per forza poi personaggi come Fubini potevano dire impunemente dalle stesse colonne che la rivalutazione aveva fatto crescere il Pil del Regno Unito. Mi sembra evidente che se una svalutazione dell’euro deprime le esportazioni europee, allora una rivalutazione della sterlina promuove quelle del Regno Unito, no? La loro economia non è priva di una coerenza interna intellettualmente appagante. C’è solo il piccolo problema che non quadra con quanto accade nel mondo reale.
A queste persone qui, prive di strumenti analitici ma molto munite di petizioni di principio, non interessa argomentare. Qualcuno si ricorda lo scambio che ebbi con l’ingegnere sulle colonne del Fatto Quotidiano? L’argomento era molto simile, e comprovava che l’uomo l’economia internazionale monetaria non la sa.
Oggi il princeps bocconianorum ci spiega che per i consumatori statunitensi i beni europei costerebbero di più se l’euro costasse di meno (in dollari, cioè appunto per i consumatori statunitensi stessi). Magari qualcuno di voi ci dovrà pensare su un po’, ma credo che nessuno di voi possa sposare una tesi così bislacca!
Ma come?
Dopo anni passati ad insultare i nostri imprenditori sulla base del presupposto che essi avrebbero cercato di promuovere slealmente l’export con svalutazioni competitive della lira (che in realtà alla luce dei fondamentali macroeconomici erano delle fisiologiche rivalutazioni del marco), adesso scopriamo che una svalutazione competitiva dell’euro danneggerebbe l’export!?
Allora, gentile ingegnere, gliela spiego così: una volta la valuta italiana si chiamava lira. Oggi si chiama euro. Ci siamo fino a qui? Spero di sì. Questo significa che una svalutazione dell’euro oggi per noi ha gli stessi effetti che aveva una svalutazione della lira ieri.
Mi segue?
Quante dita sono queste?
La aiuto: uno (e non è il pollice).
Adesso mi permetta di spiegarle un altro concetto di economia, quello di curva di domanda. Nello spazio prezzi/quantità questa curva ha pendenza negativa (diciamo derivata prima negativa, così lei, che è un ingegnere, capisce meglio). C’è qualcosa che mi ha tenuto nascosto o che non le è chiaro circa questa derivata prima? Abbiamo forse scoperto in Bocconi nell’ultima settimana che le curve di domanda hanno pendenza positiva!? Aspetti, le dico una cosa da economista che magari le serve per non aggravare la sua posizione: noi economisti sappiamo che esistono anche dei beni la cui curva di domanda ha un’inclinazione positiva, cioè che vengono acquistati in maggiori quantità se il loro prezzo cresce. Sono i beni di Giffen e costituiscono un’eccezione nel vasto panorama degli scambi economici. La regola è che se una cosa costa di più se ne acquista di meno. Di converso, se una cosa costa di meno, se ne acquista di più.
Il prezzo della valuta europea in dollari è una componente del prezzo totale in dollari dei beni europei per un consumatore americano. Se il primo prezzo (quello della valuta europea in dollari, il tasso di cambio euro/dollaro) scende, anche il secondo prezzo (il prezzo totale in dollari dei beni europei) scenderà, e quindi il consumatore americano acquisterà di più, e quindi l’Europa esporterà di più.
Non c’è altro da aggiungere se non una cosa: si faccia un favore e lo faccia a quelli che la ricordano in modo diverso da così (perché io la ricordo così)! Si ritiri, non si esponga più per fare da megafono al tizio che in Senato balbettava. Lei una reputazione, a mio avviso immeritata, ce l’ha. Se la tenga stretta tenendo cucita la bocca nel momento in cui il mondo che lei ha contribuito a costruire con le sue analisi tendenziose sta crollando. Lei è quello che nei tardi anni ‘80 ci spiegava l’opportunità fornita dal legarsi le mani con le regole europee, dall’agganciarci alle politiche della BCE. Come si sente oggi che perfino il PD ammette le gravi conseguenze deflazionistiche di quella decisione, il suo impatto devastante sui salari degli italiani, oggi che quel futuro “giapponese” che Krugman prevedeva per noi è diventato il nostro presente, oggi che le regole europee vengono tranquillamente violate da chi ce l’aveva imposte, cioè da quelli in nome e per conto dei quali lei produceva questi meravigliosi “pezzi di ricerca“?
Non c’è praticamente nulla di quello che le ha assicurato la sua reputazione che abbia retto alla prova del tempo, e quindi, ripeto, si faccia un favore, ne prenda atto.Lo dico contro il mio interesse, perché è naturalmente mio interesse far vedere la qualità pessima delle analisi che nel corso degli anni ci sono state opposte. Ma io, che non ho sulla coscienza il sangue delle tante vittime dell’austerità, so restare umano. Il rispetto per le persone anziane è uno dei pilastri della civiltà, di quella civiltà che una certa economia tanto ha fatto per estirpare, per fortuna senza riuscirci.
E quindi con rispetto le dico: la storia l’ha sconfitta.
Sappia perdere con dignità!
Post scriptum delle 13:07
Sommersi da pernacchie, e consapevoli della necessità di preservare un minimo di credibilità, al Corsera nella versione on online hanno rettificato l’errore, specificando anche l’orario in cui lo hanno fatto, seguendo in questo la prassi delle testate internazionali:
Mi limito ad osservare che la consapevolezza analitica del fatto che il dazio è uno dei tanti strumenti a disposizione per rettificare uno squilibrio commerciale noi l’avevamo già a gennaio, e che per il resto l’ingegnere non si interroga minimamente sulla causa degli squilibri (cui ha contribuito anche lui con le sue deliranti incursioni nel territorio dell’economia) e fornisce un quadro a mio avviso radicalmente contrario al vero nella valutazione relativa dell’impatto di dazi e svalutazione. Una svalutazione del dollaro sarebbe molto più penalizzante per noi, perché la corrispondente rivalutazione dell’euro ci toglierebbe anche il turismo degli Stati Uniti, compromettendo quindi non solo la nostra esportazione di beni ma anche quella di servizi.
Ah, aggiungo un dettaglio: la correzione mi pare sia avvenuta dopo questo simpatico siparietto. Ai Soloni dell’economia può capitare di finire sotto a un giornalista che ha partecipato ai convegni giusti…
sabato 29 marzo 2025
La coalizione dei volenterosi
Quello europeo è innanzitutto un progetto di propaganda ben strutturato, sorretto da un lessico peculiare, che spicca per essenzialità: poche parole a sostegno di poche idee che grazie all’incisività del lessico non appaiono molto confuse, come poi si rivelano essere alla prova dei fatti. Questa economia di concetti è ovviamente funzionale alla loro rapida e sincronica diffusione. Ogni tanto saltano fuori dal nulla parole desuete, o comunque in qualche modo decontestualizzate, e si impongono rapidamente, diventando onnipresenti: un buon esempio è la parola “resilienza”, ma ne abbiamo viste tante altre (pensiamo ad esempio all’aggettivo “giusta”, utilizzato prima per la transizione e poi per la pace).
L’ultimo arrivato in questa nidiata di stronzate luoghi comuni è il concetto di “coalizione dei volenterosi”. Va innanzitutto, detto che la traduzione non aiuta. Il fatto che le regole (e, aggiungo io, non solo quelle) siano scritte in inglese, ma pensate in tedesco, prima di essere tradotte in italiano, determina degli infelici slittamenti del campo semantico. In inglese è willing chi è intenzionato, disposto, a fare qualcosa chi cioè vuole farla, nel senso di fare quella precisa cosa. Provate a tradurre “I’m willing to cook dinner tonight” con “sono volenteroso di cucinare la cena stasera”! Chiaro il concetto, no? In italiano, viceversa, a testimonianza forse di una saggezza più antica, il concetto di “volenteroso” rinvia naturalmente a quel particolare tipo di fallimento che arriva spedito su una strada lastricata di buone intenzioni. Non a caso il nostro megafono piddino preferito, la Three dogs, come esempio dell’uso di questo aggettivo ci propone: “un allievo non molto intelligente, ma volenteroso“. Che è esattamente come sembrano gli attuali commissari influencer europei. “Volenteroso”, insomma, in italiano, che lo si voglia o no, è comunque, un cugino non troppo distante di “velleitario”, nel senso che anche quando non prelude a un fallimento, non esprime una volontà, un impegno, una disposizione precisa, ma una generica predisposizione al fare. Qualcuno direbbe: un “do something”! Sempre dalla Three dogs: “La nuova impiegata è solerte e volenterosa”. Bene! Ci fa piacere! Ma i risultati?…
Tenete a mente questo esempio, perché non è banale, tutt’altro! Il vero motivo per il quale non sarà mai possibile attivare un reale processo democratico nell’Unione Europea e che questa è un progetto pensato negli Stati Uniti e scritto in inglese, e dei suoi potenziali cittadini solo una stretta minoranza pensa in inglese. La democrazia “europea” cadrebbe rapidamente vittima dei false friends, di cui la coalizione dei “volenterosi” (che sarebbero in realtà gli “intenzionati”, cioè i malintenzionati), è un preclaro esempio.
Comunque, al netto di queste non sottigliezze ma fondamentali questioni semantiche, tutti si rendono conto del fatto che l’esistenza stessa di una coalizione dei volenterosi decreta la fine dell’Unione Europea, ma credo che pochi sappiano, anche fra voi, e nonostante io ve lo abbia già detto, che questo simpatico termine è stato inserito nel circuito della propaganda europea dall’organo principe della propaganda europea in un lavoro che teorizza la fine dell’Unione Europea!
Vale quindi la pena di ribadirlo.
A quanto mi consta, ma potrei sbagliare, una delle prime occorrenze del termine “coalition of willings” si rinviene in “Europe’s challenge and opportunity: building coalitions of the willing” pubblicato il 14 febbraio scorso su Vox da due vecchi amici del blog: Olivier e Jean (e il giorno prima su Bruegel e PIIE).
La nostra valutazione di simili coalizioni è piuttosto semplice: se in una unione a 27 per risolvere i problemi bisogna ritrovarsi in cinque, vuol dire che l’unione a 27 è inutile (me lo avete sentito dire fin dall’inizio). Questo però è un ragionamento di tipo induttivo: parte dall’esperienza concreta e ne trae una inferenza. La cosa interessante del lavoro dell’autorevole coppia invece il suo procedimento deduttivo: anziché desumere il fallimento del progetto dall’evidenza concreta, chiarisce per quali motivi il progetto non può non fallire, e questi motivi sono tanto incontestabili quanto sorprendenti se confrontati con la retorica dei cosiddetti Stati Uniti d’Europa (sui quali pesa il verdetto del compagno Lenin, che non necessita di essere contestualizzato, essendo tuttora attualissimo, a differenza dei deliri di alcune persone probabilmente sottoposte ad una dieta povera di calorie).
Partendo, come usa fare di questi tempi per rafforzare argomenti farlocchi, dal presupposto che vi sia una minaccia esterna (che per l’autorevole coppia è costituita da Trump, non da Putin), i nostri cari amici ci dicono che l’Unione Europea non può però contrastarla per due motivi: è troppo piccola ed è troppo divisa. Al problema delle dimensioni si può ovviare, paradossalmente, creando delle alleanze a geometria variabile che però coinvolgano anche Stati non membri: gli ipotetici allargamenti previsti, che si tradurrebbero nel caricarsi a bordo una manica di derelitti, non risolverebbero il problema, così come non lo risolverebbe l’unione politica, perché il tutto sarebbe pur sempre la somma delle parti. Naturalmente con la stessa metodologia si risolve anche il problema delle divisioni: basta partire da un nucleo di Stati che abbiano idee sufficientemente omogenee su un determinato problema. Questo ragionamento, che vi invito a leggere sulla fonte originale, sancisce al tempo stesso il fallimento di un processo di integrazione totalitario, tutto incentrato sul feticcio del cosiddetto acquis communautaire, un dato a noi sufficientemente chiaro da tempo grazie alle analisi di Giandomenico Maione:
e, paradossalmente, la lungimiranza e il potenziale successo (nonostante gli attuali fallimenti, derivanti dal carattere estemporaneo delle iniziative e dalla loro volontà di convivere con un quadro istituzionale profondamente sbagliato, come quello unione) di quella ristrutturazione dell’integrazione europea in un sistema di giurisdizioni funzionali sovrapposte di cui parlava Bruno Frey e che qui conoscete da tempo.
Questo giusto per sottolineare una cosa: quello che gli abbietti operatori informativi hanno da sempre banalizzato come un lavoro puramente “ventrale“ di contestazione velleitaria, pregiudiziale, demagogica dell’ordine naturale delle cose, in realtà è stato qualcosa di totalmente diverso: un lavoro di analisi e di proposta su cui, alla fine, anche chi ha strenuamente difeso l’indifendibile è costretto a convergere.
DVCVNT VOLENTES FATA NOLENTES TRAHVNT.
Questo non ve lo dice LVI, ma io, quindi succede e, appunto, la “coalizione dei volenterosi” è uno dei tanti casi in cui è successo! Rilassatevi quindi: la fine dell’incubo è ormai apertamente teorizzata. Questo naturalmente prelude a incubi peggiori, se non si intercetta correttamente e non si gestisce il momento “rivoluzionario”. Per questo contiamo sulla vostra attenzione e sul vostro sostegno.
venerdì 28 marzo 2025
Il paradosso del dazio
Mentre affrontavo le consuete polemiche quotidiane sui "dazi di Trump" col mellifluo Richetti e col decisivo Giarrusso mi è venuta una sorta di illuminazione: strano che quella svalutazione della valuta nazionale che tutti deprecavano quando era in realtà rivalutazione di una valuta estera si sia tramutata in una pratica tollerata, o addirittura apprezzata, quando è diventata effettivamente una svalutazione della valuta nazionale!
Credo che abbiate capito, ma esplicito.
Quelli che accusavano con palese disprezzo la nostra classe imprenditoriale di vivacchiare a suon di "svalutazioni competitive" in un periodo in cui era il marco tedesco a rivalutarsi a causa del forte surplus della Germania, sono poi stati zitti o hanno addirittura plaudito al deprezzamento della valuta italiana, l'euro, in un contesto che era chiaramente quello di una svalutazione competitiva perché, guarda caso, l'Eurozona era in surplus (e quindi l'euro si sarebbe dovuto apprezzare).
Insomma: quando le cose andavano come dovevano, ci si lamentava. Quando hanno cominciato ad andare al contrario, ci siamo detti che stava andando tutto bene, ma qualcuno aveva avvertito che questa bonanza non poteva durare per sempre:
(era il 20 gennaio 2015: ora a Piazza Lurida per non avermi in trasmissione raccontano che non sono efficace: giudicate un po' voi: "gli Stati Uniti si adonteranno!", e si sono adontati e come!).
La solita storia: quando non entra in testa...
Agli imprenditori dico di stare molto attenti alla narrazione di chi, disprezzandoli dal profondo, li ha messi in cattive acque lusingandoli prima con la narrazione dell'euro che li avrebbe protetti, poi con quella delle virtù salvifiche dell'austerità, e poi con quella dei benefici di politiche commerciali scorrette e provocatorie nei riguardi degli Usa (l'esempio di questo video). Suggerirei invece il metodo di farsi dire delle verità, ancorché amare, da chi le sa (noi), e di tenerne il debito conto. Chi lo ha fatto, finora, non si è trovato male.
Quale sia la strada da seguire i più illuminati lo sanno, ed è ovviamente quella di sciogliersi dall'asse Roma-Berlino-Turku e andare a trattare bilateralmente con gli Usa, partendo dal presupposto che il metodo secondo cui per fare il bene del tutto bisogna fare il male delle parti non ha funzionato (e quindi ora basta: facciamo il bene nostro, sarà un bene anche per l'Europa, e se non lo fosse per l'Unione Europea: meglio)!
(...a proposito: ma Passera che fine ha fatto? Non lo incontro mai! Sta bene?...)
(...fisicamente, intendo: quando c'è la salute c'è tutto!...)
giovedì 27 marzo 2025
La Croazia due anni dopo
Ce l'avete Instagram?
E allora guardatevi questo reel:
Oibò! Che starà mai succedendo? Quale inaudita e inattesa vicissitudine porta i croati, un tempo fornitori di servizi di turismo a buon mercato, ad accaparrarsi merci a buon mercato nel capoluogo italiano?
Ripartiamo da quello che ci eravamo detti due anni fa: la variabile da tenere d'occhio era il tasso di inflazione:
Il motivo credo lo sappiate: un tasso di inflazione superiore alla media dei partner commerciali determina un incremento del tasso di cambio reale (cioè del prezzo dei beni nazionali rispetto a quelli esteri, cioè una diminuzione di competitività), e quindi un aumento delle importazioni di merci, e conseguentemente (non spiaccia a Barisoni) di quelle di capitali. Si vive così al disopra dei propri mezzi, cosa che accade non quando si fa debito pubblico, ma debito privato, e ci si avvita nel ciclo di Frenkel (che descrivemmo qui in modo scherzoso come Romanzo di centro e di periferia, e qui in modo un po' più tecnico), fino all'inevitabile botto finale.
La moneta unica che cosa c'entra in questo deterioramento della competitività? C'entra attraverso i noti canali: se è troppo forte per l'economia che la adotta, incentiva i consumi (in particolare quelli di prodotti esteri) e quindi gli afflussi di capitale estero che alimentano la bolla del credito al consumo e quella immobiliare, favorite anche dal fatto che moneta forte implica che il tasso di interesse sia più basso del suo ipotetico valore di equilibrio, il che costituisce un ulteriore incentivo all'indebitamento di imprese e soprattutto famiglie. Che cosa potrà mai andare storto alla fine di questa storia risaputa?
Lo sapete (anzi: lo risapete)!
In effetti, non si può dire che le autorità croate siano riuscite a tenere l'inflazione sotto controllo. Se ricostruiamo i tassi di inflazione tendenziale mensile (mese su stesso mese dell'anno precedente) usando l'HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) fornito da Eurostat, otteniamo questo:
e indubbiamente mentre l'Italia è riuscita a contenere il proprio picco inflattivo, tornando abbastanza rapidamente sotto la media europea, lo stesso non può dirsi della Croazia. Se usiamo i dati annuali del WEO (il solito database) vediamo questa situazione:
Nel biennio 2023-2024 (cioè nei suoi due anni di permanenza nell'euro, cioè da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta) la Croazia ha cumulato 5,2 punti di differenziale di inflazione nei riguardi dell'Italia (cioè: in media oggi i beni croati costano un po' più del 5% in più rispetto a quelli italiani...), che con i dati Eurostat (più aggiornati) diventano 5,4 punti.
Dato che buona parte del commercio della Croazia avviene verso l'Italia (siamo il secondo partner commerciale a poca distanza dalla Germania, lo potete verificare qui), possiamo supporre che questo differenziale si sia tradotto in un apprezzamento del tasso di cambio della Croazia intorno a quell'ordine di grandezza. In effetti, guardando i dati Eurostat sul monitoraggio degli squilibri macroeconomici
vediamo che per quanto riguarda il tasso di cambio reale l'apprezzamento sugli ultimi tre anni è stato pari al 5,4% (6% nell'ultimo biennio). Siamo lì. In Italia i numeri sono rispettivamente 0,7% (nel triennio) e 2,2% (nel triennio), a indicare una perdita di competitività di prezzo molto più lieve.
Un pezzo di questa persistenza dell'inflazione è senz'altro attribuibile a una caratteristica strutturale della Croazia, quella di avere una bilancia dei pagamenti vicina all'equilibrio come risultante di due forze (vi ripropongo il grafico di due anni fa):
forti esportazioni di servizi (turismo), controbilanciate da forti importazioni di merci. Le forti importazioni di merci determinano una forte importazione di inflazione in un contesto di shock internazionale di offerta, ma naturalmente oltre a questo c'è dell'altro, ed è quello che ci aspettiamo ci sia. Ma prima di dirvelo, vi rimetto qui la teoria del ciclo di Frenkel, altrimenti quando in Croazia i giornali intitoleranno "požuri se!" il forestiero verrà qui a dire che ho solo avuto fortuna e che l'economia non è una scienza. La teoria, esposta qui, ci dice questo:
I primi due punti sono assorbiti dalla appartenenza all'Unione Economica e Monetaria. Circa il terzo punto, la diminuzione dei tassi di interesse c'è stata (in effetti, dal 2018 la Croazia ha tassi di interesse più bassi dell'Italia), l'aumento dei prezzi l'abbiamo visto nel grafico, l'aumento del tasso di crescita c'è stato:(dati qui), anche se, naturalmente, trattandosi di un Paese che parte da un livello di reddito pro-capite inferiore al nostro questo scarto è veramente difficile da distinguere da quello determinato dal fisiologico processo di catch-up (di cui abbiamo parlato qui), e l'aumento dell'occupazione pure (la disoccupazione è scesa dal 6,8% del 2022 al 5% del 2024, un minimo storico, dati qui).
Tutto questo però non dà sufficienti segnali di allarme, a mio avviso. I dati più significativi sono quelli riferiti alla fase 4, e lì in effetti qualche problema si riscontra. Ad esempio questo:
cioè il tasso di crescita del credito erogato alle famiglie, che sta crescendo molto rapidamente verso la soglia di attenzione del 14% (qui ho considerato i cinque Paesi più vicini alla soglia nel 2023: solo la Bulgaria è oltre la soglia, ma solo la Croazia è in crescita così rapida), ma anche un indicatore che possiamo immaginare collegato al credito, e indicativo di potenziali bolle, cioè questo:
il tasso di crescita dei prezzi degli immobili. La Croazia sta messa bene anche sul flusso di credito alle imprese, ma va detto che il rapporto debito delle imprese/Pil è basso e in lieve calo, come pure che il saldo delle partite correnti sta tenendo, nonostante l'apprezzamento del cambio reale:
C'è la solita fragilità strutturale (il turismo che compensa un saldo merci in sprofondo rosso), ma il saldo complessivo (barre) resta in equilibrio.
Resta da capire come andrà avanti questa cosa:
perché se la spezzata grigia dovesse cominciare a scendere, si tirerebbe giù le barre blu, e allora si arriverebbe al punto 4.b dello schema qua sopra.
Non ci siamo ancora, naturalmente, e non è detto che ci si arrivi. Il primo ciclo di Frenkel dei Paesi periferici dell'Eurozona si avviò quando la sorveglianza macroeconomica praticamente guardava solo il rapporto deficit pubblico/Pil. Ora tutti possono guardare gli indicatori che nel 2010-2011 guardavamo solo noi, e a nessuno va di fare la fine della Grecia. Quindi può benissimo darsi che una saggia classe politica croata decida di anticipare un po' di medicina amara, tirando i remi in barca prima di andare a sbattere, aiutata in questo dalla prudente supervisione europea. Può benissimo darsi, giusto?
Ci rivediamo fra un paio d'anni...